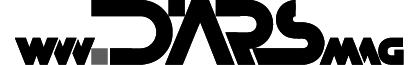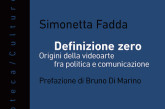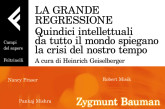I grandi cambiamenti a livello tecnologico e sociale implicano una specifica percezione della temporalità. Nel salto dall’accelerazione moderna all’istantaneità del mondo digitale anche il tempo biologico dell’individuo viene continuamente riscritto e ripensato. L’abbattimento delle strutture gerarchiche a favore di una dimensione orizzontale di scambio ha favorito un livellamento dei classici cicli di vita che scandiscono tradizionalmente le tappe di un percorso esistenziale. Oggi siamo più portati a focalizzarci sulle analogie (gruppi, like, match di algoritmi) e, dunque, a omogeneizzare in qualche modo la complessità delle differenze concrete che pur continuano a persistere tra un adulto e un giovane, per esempio. La giovinezza diventa uno stato prolungabile e assoluto, una forma di vita tout-court, la più auspicabile. Questo genera una posticipazione e, al contempo, una svalutazione della vecchiaia che influenza anche le forme di trasmissione e il significato più profondo dell’eredità immateriale.
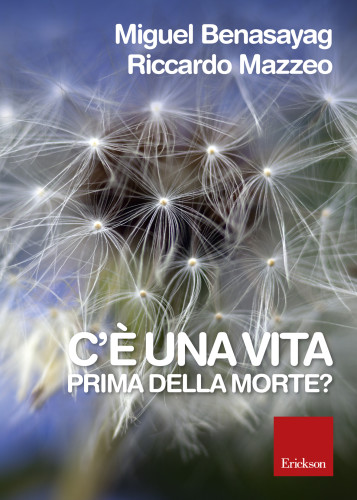
La conclusione di un percorso può offrire una buona occasione per riflettere sulla finitudine. Il rumore secco di una porta che si chiude alle nostre spalle provoca dei sussulti e delle vibrazioni che ci accompagneranno nella nuova direzione. La trasmissione reclama un contesto asimmetrico, impreciso, appena supposto, per articolarsi: è un gesto che non spiega ma piuttosto rivendica una presenza e in essa preconizza la possibilità di un dialogo, auspica legami e attribuzioni di senso. L’ars vivendi si pratica al gerundio ovvero dentro a un movimento sisifico(1) del fare e disfare dal quale non siamo mai esclusi; perciò un’esperienza di vita non può essere ridotta a una curva statistica o una mera analisi dei costi/benefici. Il modello post-capitalista del progetto come feticcio passe-partout per catalizzare fondi, come strumento strategico per affermarsi e generare profitto corrisponde a un tentativo mortifero di normalizzazione. Al contrario c’è in ogni fine un moto liberatorio, uno scatto di ribellione che vuole tracciare la sua continuità oltre le logiche contingenti. È un momento di riavvicinamento alla finitudine nel suo scarto esistenziale che rigetta qualsiasi visione lineare del progresso, è la riaffermazione di un tempo altro.
Nel libro-dialogo C’è una vita prima della morte?(2) il filosofo e psicoanalista Miguel Benasayag abbraccia la temporalità da una prospettiva spinoziana: “Per il pittore, l’innamorato, il liberatore, il ricercatore, per chi viva sul serio qualcosa e assuma la situazione presente, questa situazione presente in una X di sfida non è né corta né lunga, è atemporale. È l’eternità di Spinoza. Per contro c’è una riduzione di questa dimensione di eternità, di intensività pura, ogni volta che ci si istalli nel tempo lineare dell’orologio, che è il tempo non del presente, ma dell’immediatezza permanente in cui un immediato segue un altro immediato. (…) Nell’immediato il passato non ha importanza perché l’immediato è il tempo della tecnica. (…) Una simile temporalità centrata sull’immediatezza cancella il fatto che un anziano non abiti il presente con le stesse dimensioni di un giovane.”(3)
[1. Albert Camus, Il mito di Sisifo, Bompiani (Milano, 1947)]
[2. Miguel Benasayag, Riccardo Mazzeo, C’è una vita prima della morte?, Erickson (Trento, 2015)]
[3. Ibidem, pag. 130]
Clara Carpanini
D’ARS anno 56/n. 223/estate 2016 (incipit dell’articolo)